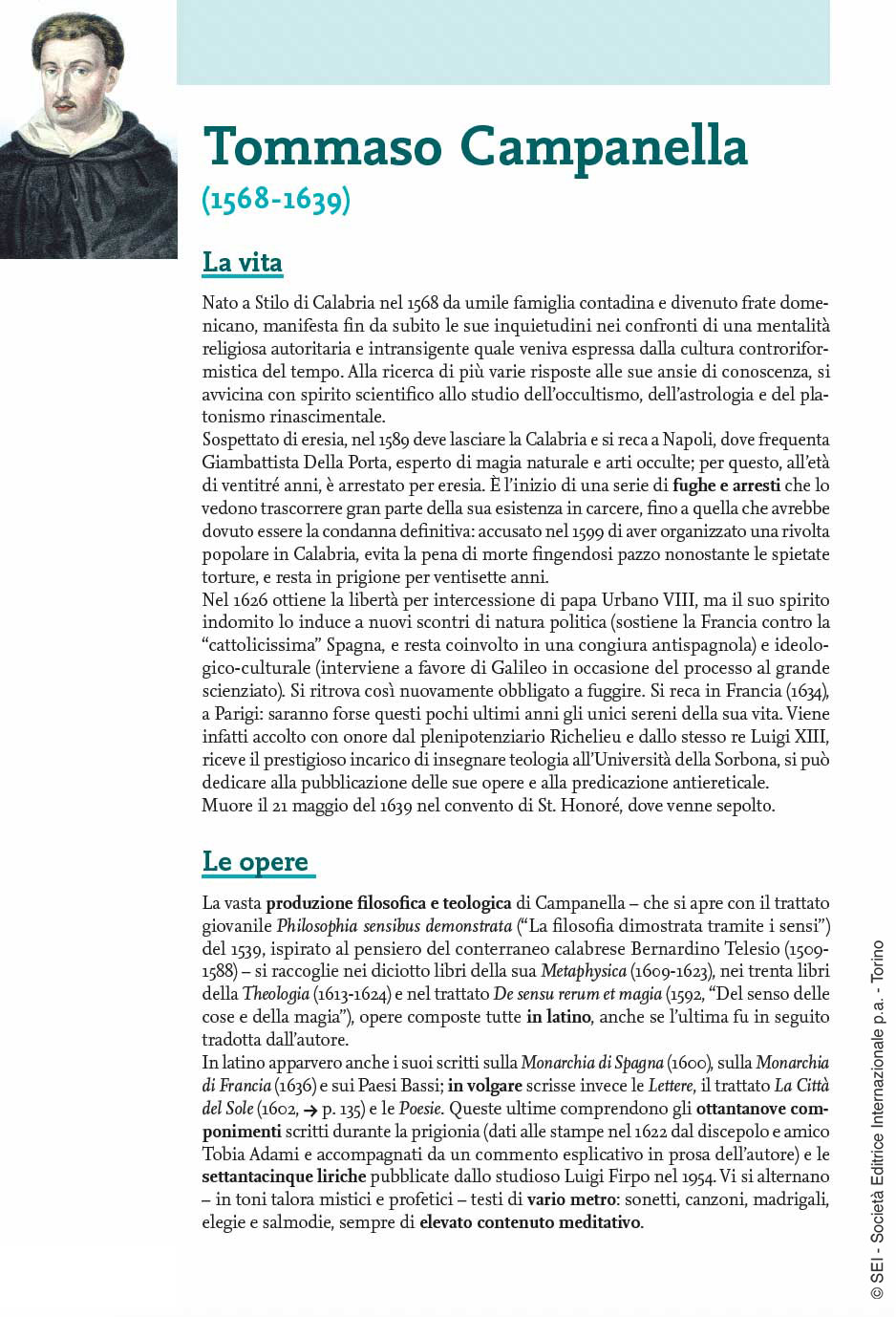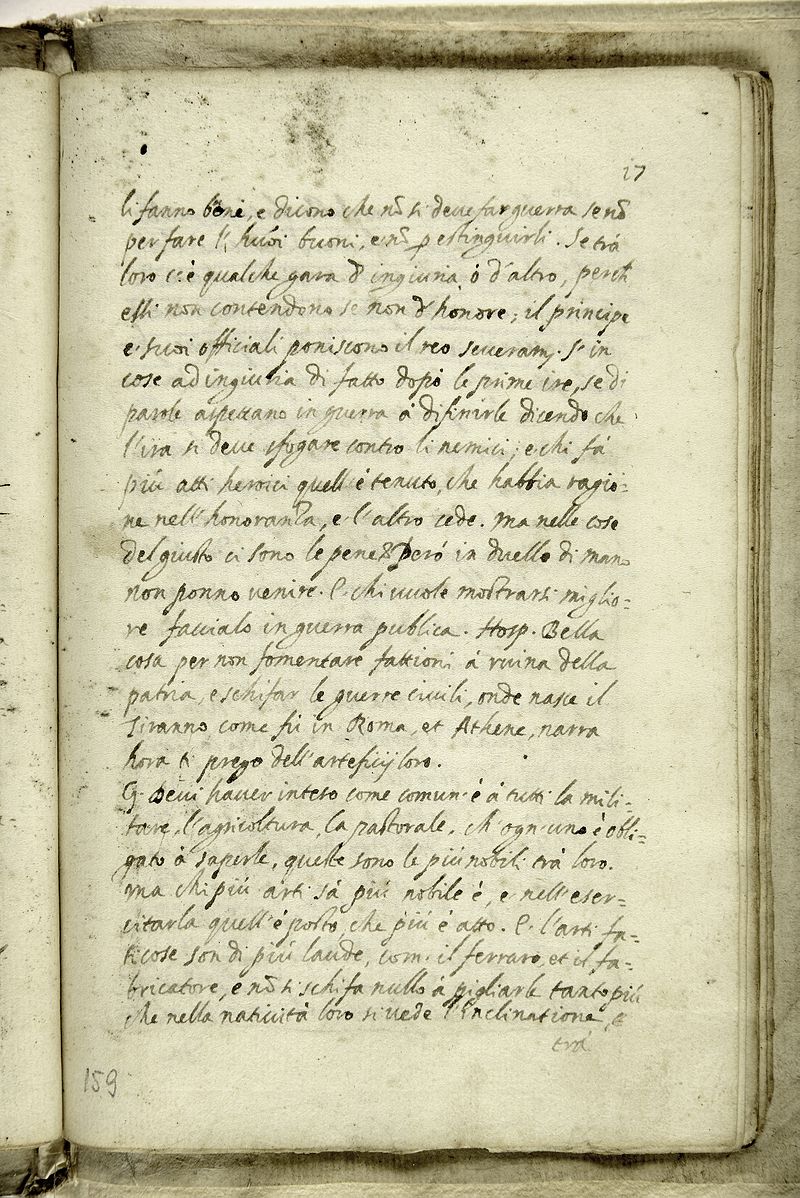Sul testo
La vita e le opere di Tommaso Campanella
La Città del Sole (1602)
Ne La Città del Sole del 1602 Campanella espone – sull’esempio dell’Utopia di Tommaso Moro – il proprio progetto politico. Concepita come un dialogo, l’opera narra di un cavaliere che a Gerusalemme interroga un nocchiero di Cristoforo Colombo, reduce dalla circumnavigazione del mondo e dalla scoperta di una Città del Sole in un’isola orientale chiamata Taprobana. La città è posta su una collina ed è suddivisa in sette cerchi concentrici (i pianeti allora conosciuti). Sulla sommità c’è un tempio, da cui un sacerdote scelto per le sue qualità e competenze – il Metafisico – gestisce il potere. Tutto è controllato con rigore, sia le funzioni pubbliche (la divinità è una sola, simboleggiata dal Sole) sia quelle private. Non vi sono riti funebri, i corpi vengono bruciati perché l’anima del defunto torni al Sole. In sostanza, l’intera organizzazione è basata sulla comunità e socializzazione dei beni, in un’armonica divisione delle ricchezze e dei compiti e in una prospettiva profetica da cui emerge l’attesa di una palingenesi politica e religiosa, all’insegna di un Cristianesimo totalmente rinnovato, conciliato con la natura e con la ragione. La Città del Sole si colloca sulla linea inaugurata dalla Repubblica di Platone, e ripropone quegli stessi principi cui si era ispirata, un secolo prima, l’Utopia di Tommaso Moro. Campanella rappresenta qui la sua “isola Utopia” nella forma di una società ideale organizzata secondo leggi precise e razionali, ma adotta come riferimento un ambiente lontano, “esotico”, quasi fantasioso: un espediente per non suscitare sospetti nei politici contemporanei, cui pure l’opera è diretta come sollecitazione a rinnovamenti sociali.