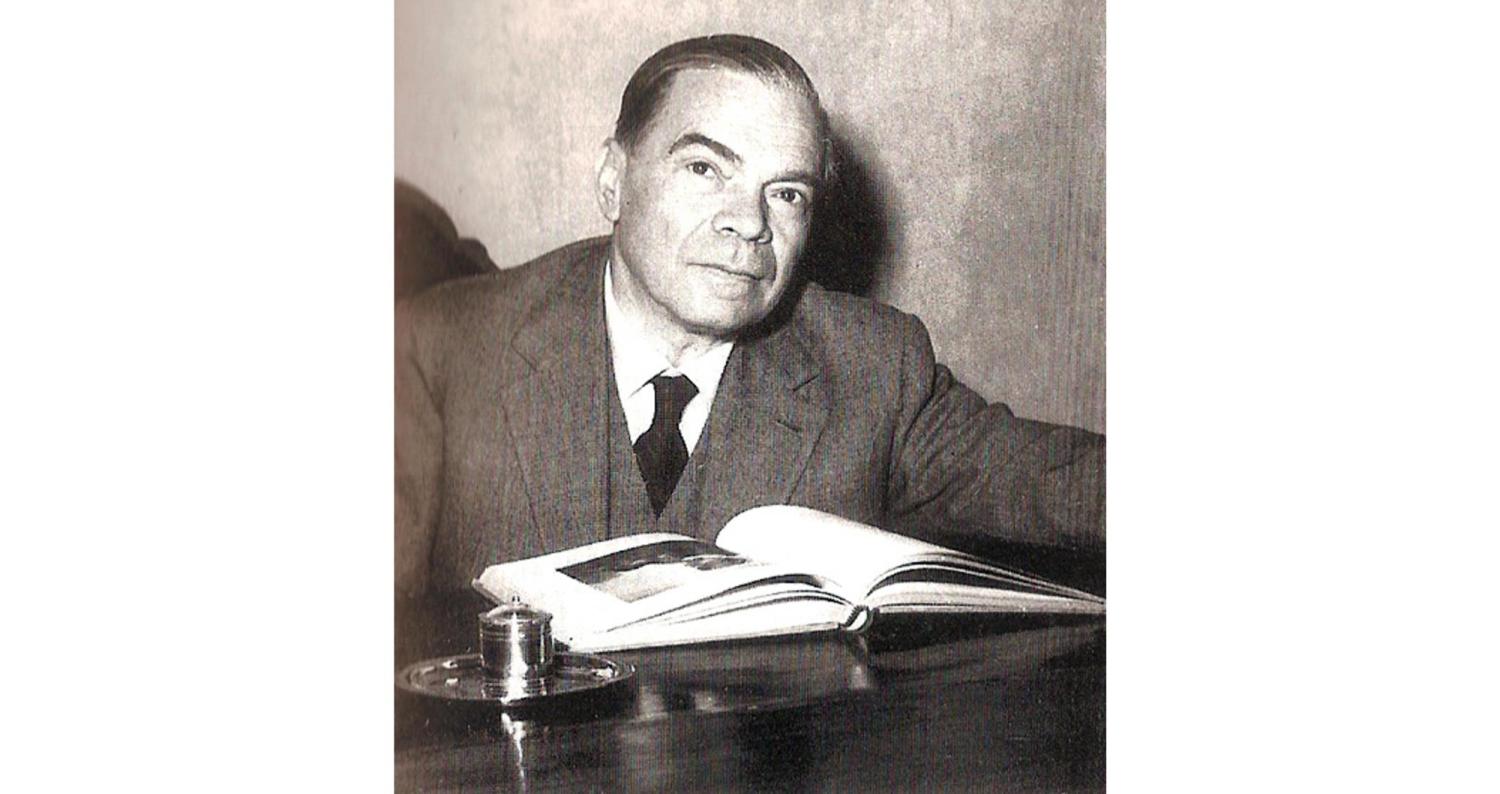Corrado Alvaro
Corrado Alvaro (1895-1956) nasce a Reggio Calabria, partecipa alla Prima guerra mondiale e dal fronte intraprende l’attività giornalistica, che continuerà anche al suo ritorno. Nel 1925 è tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Dopo aver pubblicato una raccolta poetica e due romanzi, nel 1930 dà alle stampe la raccolta di racconti Gente in Aspromonte: continuerà poi l’attività giornalistica, alternandola con quella di narratore. Nel romanzo del 1938 L’uomo è forte, scritto al ritorno da un viaggio in Russia, esprime la sua critica al totalitarismo russo, che gli vale l’accusa di fascista da parte della cultura legata alla sinistra; ma egli non aderirà mai al fascismo.
Gente in Aspromonte (1930)
Nella raccolta di racconti Gente in Aspromonte (il massiccio montuoso dell’Appennino calabro) Alvaro rappresenta la vita dei pastori nei primi del Novecento, in perpetua lotta con la miseria e con la natura aspra e selvaggia. Le condizioni di arretratezza socio-economica che caratterizzano la vita dell’Aspromonte permettono all’autore di spiegare sia l’iniziale adesione della popolazione alle promesse di miglioramento del regime fascista sia l’adesione al brigantaggio.
Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, il pastore Argirò, che per un incidente ha perduto la mandria, è cacciato dal padrone Filippo Malatesta e precipita nella miseria. Con il proprio lavoro riesce finalmente a comprarsi una mula, ad avviare un piccolo commercio e a indirizzare agli studi uno dei figli, mentre l’altro (Antonello) lavora lontano per dare sostegno alla famiglia. Ma gli eredi del padrone gli uccidono l’animale e Antonello decide di vendicarsi: incendia le terre dei proprietari e ne stermina le greggi, distribuendone le carni ai poveri, finché viene incarcerato.
In Alvaro si assiste a una schematizzazione piuttosto sommaria – i pastori miseri e buoni contrapposti ai proprietari malvagi – che tuttavia risponde al tono epico della narrazione, mentre la mentalità primitiva e superstiziosa dei protagonisti evoca talora uno scenario di favola o di leggenda (ed è leggendaria la figura del bandito che ripara le ingiustizie): ma anche nella vicenda di Antonello si intravedono una risposta alla disperazione e un faticoso percorso verso la presa di coscienza della propria dignità, come traspare dall’amara battuta che egli pronuncia al momento dell’arresto: «Finalmente, disse, potrò parlare con la Giustizia. Ché ci è voluto per poterla incontrare e dirle il fatto mio!».
La tematica sociale e il meridionalismo
Nella narrativa italiana degli anni Trenta risaltano le opere di alcuni autori in cui emerge una denuncia delle condizioni di arretratezza in cui sono confinate le popolazioni che vivono nelle regioni meridionali e, nello stesso tempo, una forte tensione etica, che si traduce anche in impegno civile e politico. Si tratta di romanzi ispirati a un Realismo sociale che assume diverse declinazioni negli autori più rappresentativi.
Corrado Alvaro fu la voce di una narrativa meridionale che negli anni del fascismo riproponeva con moduli originali i temi della diseguaglianza e dello sfruttamento, con una sensibilità sociale che nascondeva una critica implicita – ma talora dichiarata – alla retorica del regime. L’opposizione politica diventa aperta e motivata nell’abruzzese Ignazio Silone e nella sua aspra denuncia della condizione contadina.
La città e le contraddizioni della nascente realtà industriale e la difficile crescita di una coscienza di classe sono lo sfondo dell’opera di Carlo Bernari. Il torinese Carlo Levi dedicò alle plebi della Lucania il suo capolavoro, scritto negli anni della guerra a seguito del suo lungo confino – come antifascista – in quelle terre.
Sul piano stilistico prevale, in questi autori, la ricerca di una lingua depurata dai virtuosismi e da un’artificiosa eleganza, attraverso una sintassi per lo più breve e poco articolata, che a tratti richiama la “viva voce” dei personaggi.