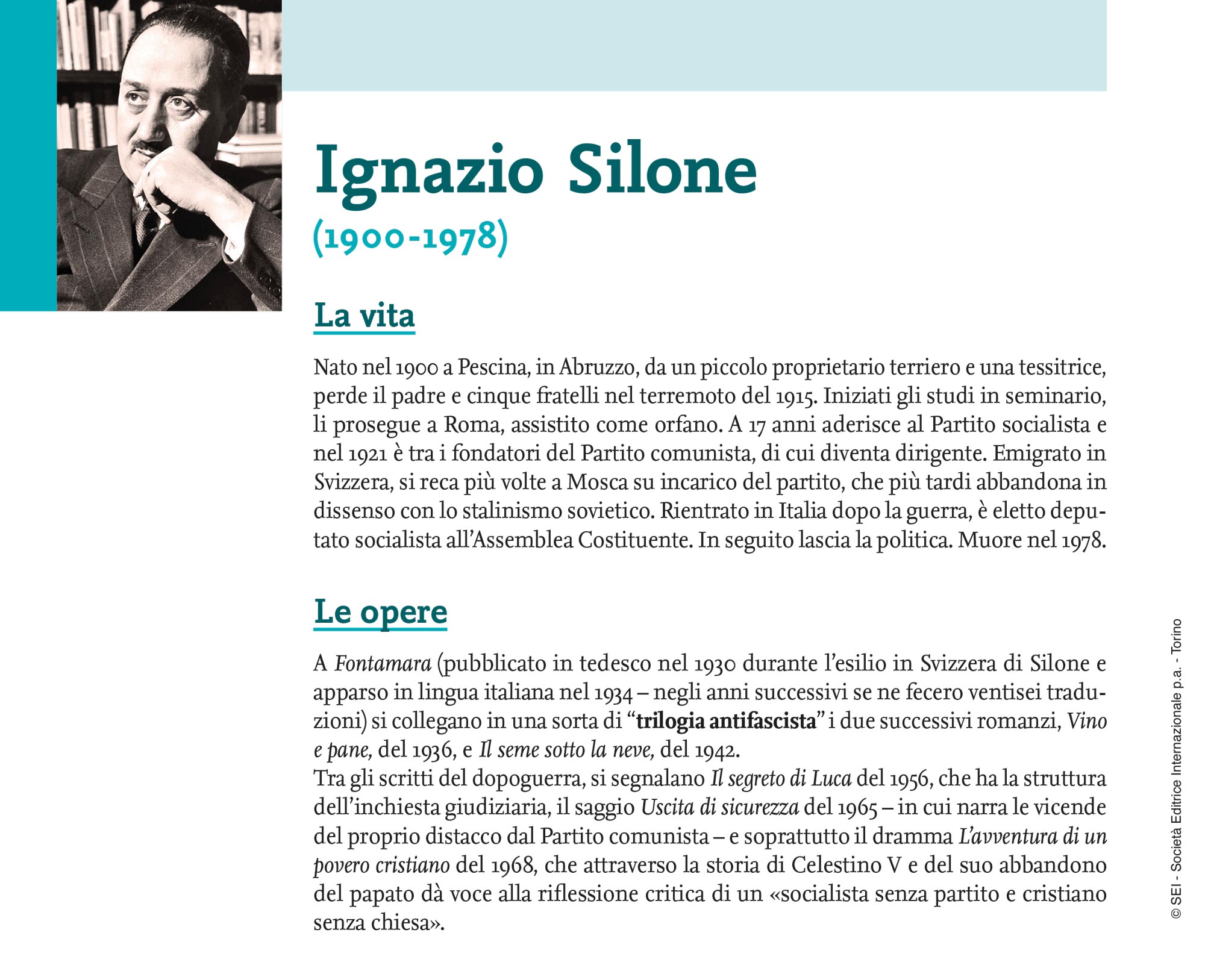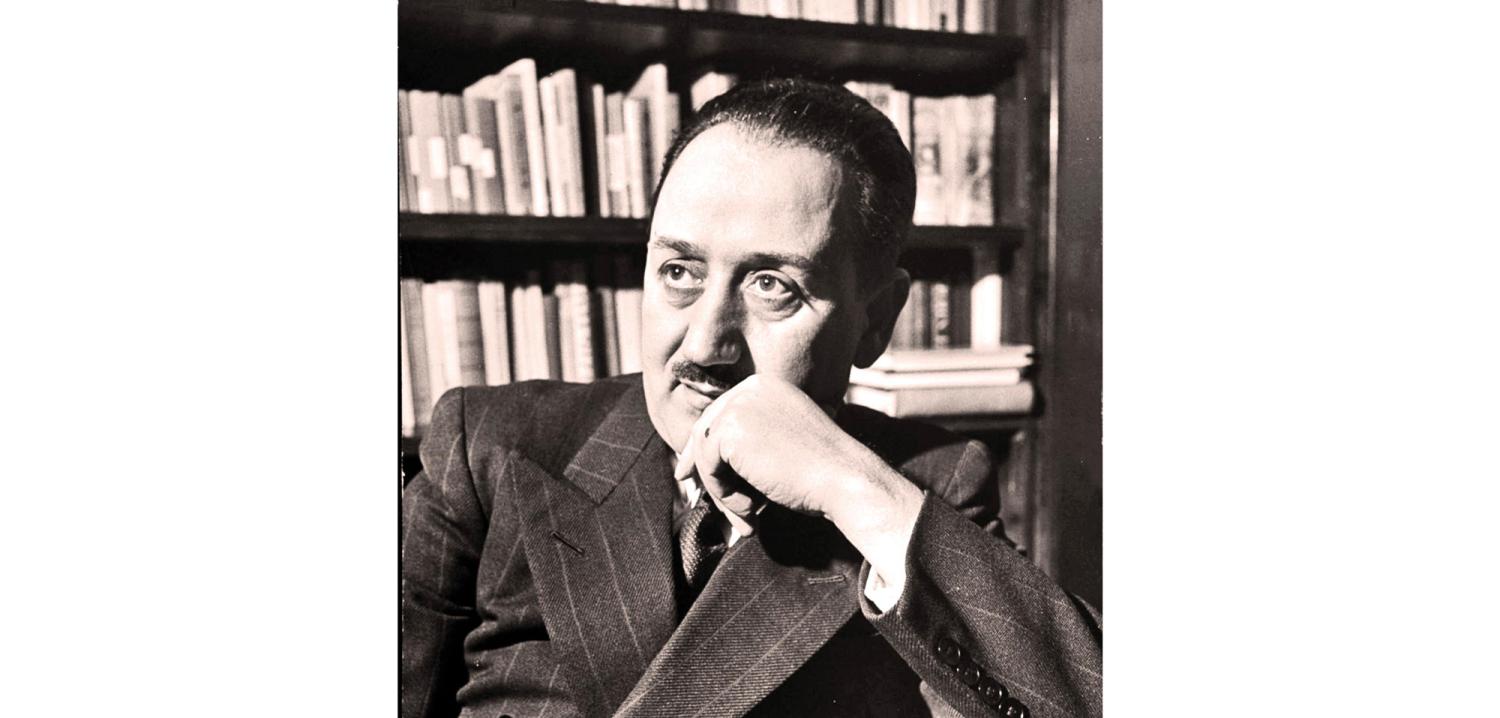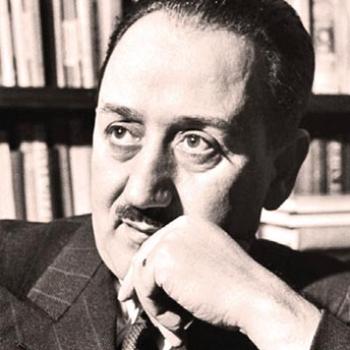
Sul testo
La vita e le opere di Ignazio Silone
Fontamara (1930)
L’intento di non “tradire” la voce dei protagonisti e la “verità” della loro storia è espresso da Ignazio Silone nella prefazione al romanzo Fontamara. In un villaggio della Marsica abitato da contadini – i cosiddetti cafoni – che sopravvivono a stento, un ruscello che da secoli irriga i loro terreni viene deviato per irrigare quelli dell’Impresario, un affarista protetto dal regime. I cafoni si ribellano, subiscono una spedizione punitiva dei fascisti, vengono schedati come sovversivi. Uno di loro, il giovane Berardo Viola, va a Roma per protestare, ma viene arrestato. In carcere conosce un antifascista e prende coscienza dei propri diritti, ma viene torturato e ucciso. Tuttavia, dopo la sua morte a Fontamara qualcosa cambia: sta nascendo un giornale. Non lo si potrà intitolare «La giustizia», perché «da noi, giustizia ha sempre significato i carabinieri», ma lo si chiamerà «Che fare?».
Con il suo forte impegno ideologico e la struttura narrativa corale incentrata su un eroe positivo, il romanzo non dà spazio né alle descrizioni, né all’analisi psicologica: nato sulla spinta di una «assoluta volontà di testimoniare», si colloca al di fuori della tradizione letteraria e anche di quella linguistica, perché l’italiano per i fontamaresi – di cui l’autore si fa portavoce – è «una lingua straniera, una lingua morta».
La tematica sociale e il meridionalismo
Nella narrativa italiana degli anni Trenta risaltano le opere di alcuni autori in cui emerge una denuncia delle condizioni di arretratezza in cui sono confinate le popolazioni che vivono nelle regioni meridionali e, nello stesso tempo, una forte tensione etica, che si traduce anche in impegno civile e politico. Si tratta di romanzi ispirati a un Realismo sociale che assume diverse declinazioni negli autori più rappresentativi.
Corrado Alvaro fu la voce di una narrativa meridionale che negli anni del fascismo riproponeva con moduli originali i temi della diseguaglianza e dello sfruttamento, con una sensibilità sociale che nascondeva una critica implicita – ma talora dichiarata – alla retorica del regime. L’opposizione politica diventa aperta e motivata nell’abruzzese Ignazio Silone e nella sua aspra denuncia della condizione contadina.
La città e le contraddizioni della nascente realtà industriale e la difficile crescita di una coscienza di classe sono lo sfondo dell’opera di Carlo Bernari. Il torinese Carlo Levi dedicò alle plebi della Lucania il suo capolavoro, scritto negli anni della guerra a seguito del suo lungo confino – come antifascista – in quelle terre.
Sul piano stilistico prevale, in questi autori, la ricerca di una lingua depurata dai virtuosismi e da un’artificiosa eleganza, attraverso una sintassi per lo più breve e poco articolata, che a tratti richiama la “viva voce” dei personaggi.