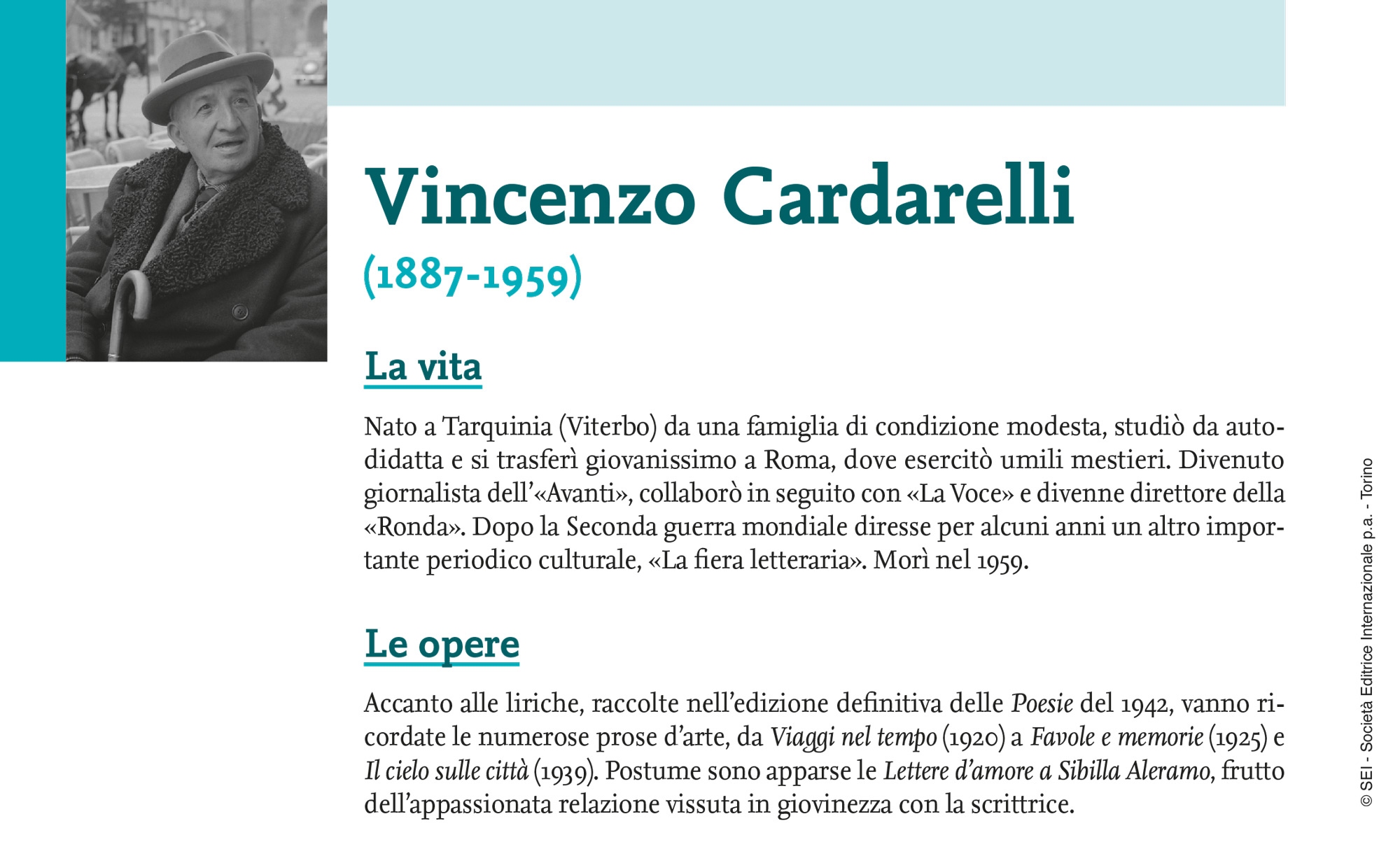Sul testo
La vita e le opere di Vincenzo Cardarelli
Viaggi nel tempo (1920)
La volontà di ripresa della tradizione, specialmente leopardiana, è alla base della poesia di Cardarelli, giornalista per «La Voce» e poi tra i fondatori di «La Ronda», e autore di varie raccolte a cominciare dai Prologhi del 1916 e dalle «prose d’arte» dei Viaggi nel tempo del 1920. L’intenzione di Cardarelli è quella di andare oltre il frammentismo e l’oscurità delle avanguardie – e degli ermetici – per ricostruire un discorso colloquiale e disteso, in cui riaffiorano con tono elegiaco soprattutto le memorie dell’infanzia e dell’adolescenza, le descrizioni paesistiche e il tema della solitudine. Il poeta non rinuncia a un’esplicita e talora esibita prosaicità, costruita attraverso il ricorso a immagini o espressioni tratte dal quotidiano, mentre da Leopardi attinge la forza di suggestione ed evocazione lirica delle “parole” (e l’ossessione ricorrente dello scorrere del tempo) piuttosto che la polemica o l’aspra meditazione esistenziale. Prevale un atteggiamento di disimpegno nei confronti della società e della storia, nutrito di aristocratico distacco e di abilità retorica, che ha indotto i critici a ricondurre questa poesia all’interno della categoria del “classicismo” ed entro il quadro più generale di quel “ritorno all’ordine” – ovvero a un raffinato classicismo formale – che veniva promosso sulle pagine della «Ronda» e trovava riscontro anche nella pittura o nell’architettura di quegli anni. La formula è quella suggerita dall’articolo pubblicato sul primo numero della «Ronda»: «uno stile defunto [...] per realizzare nuove eleganze».