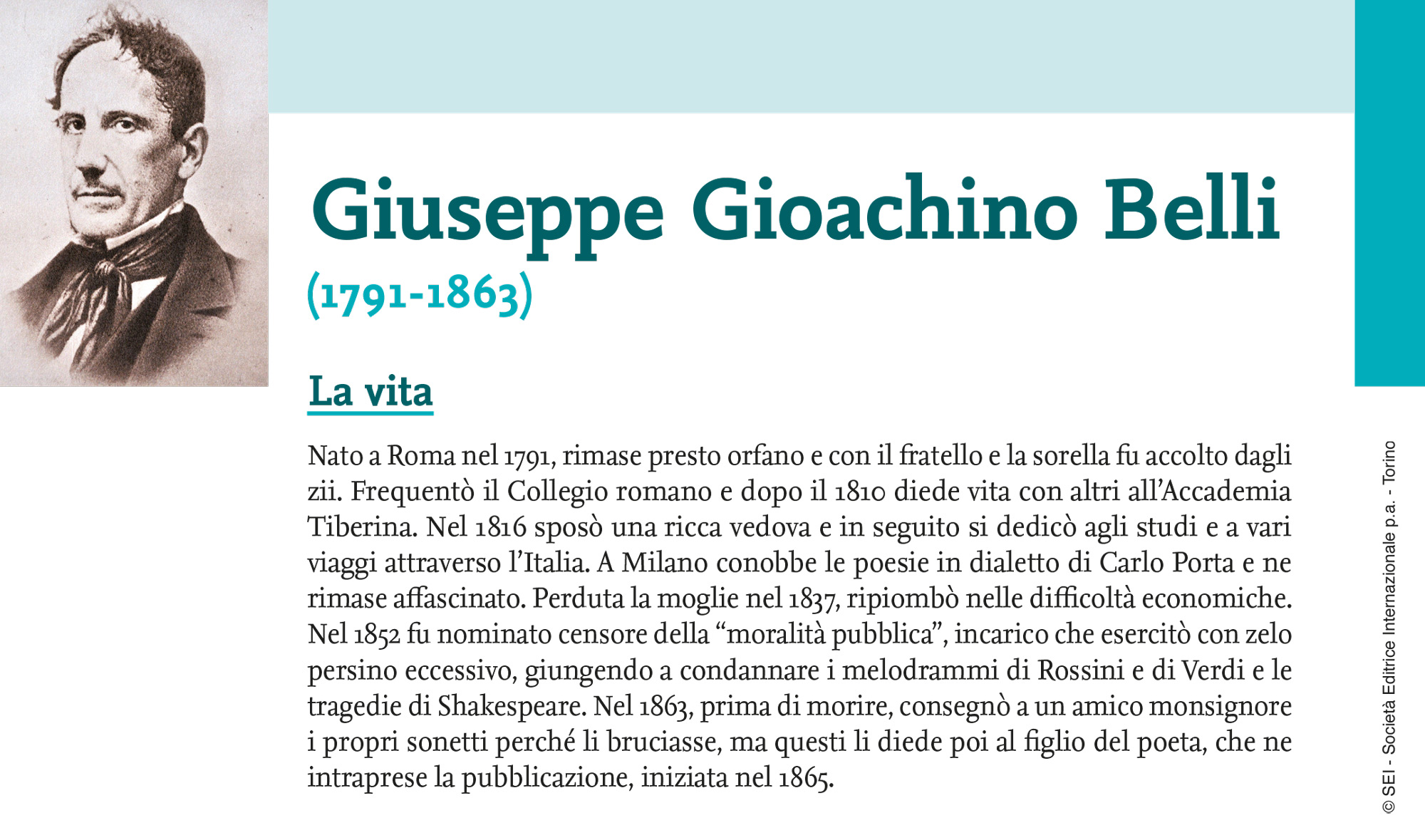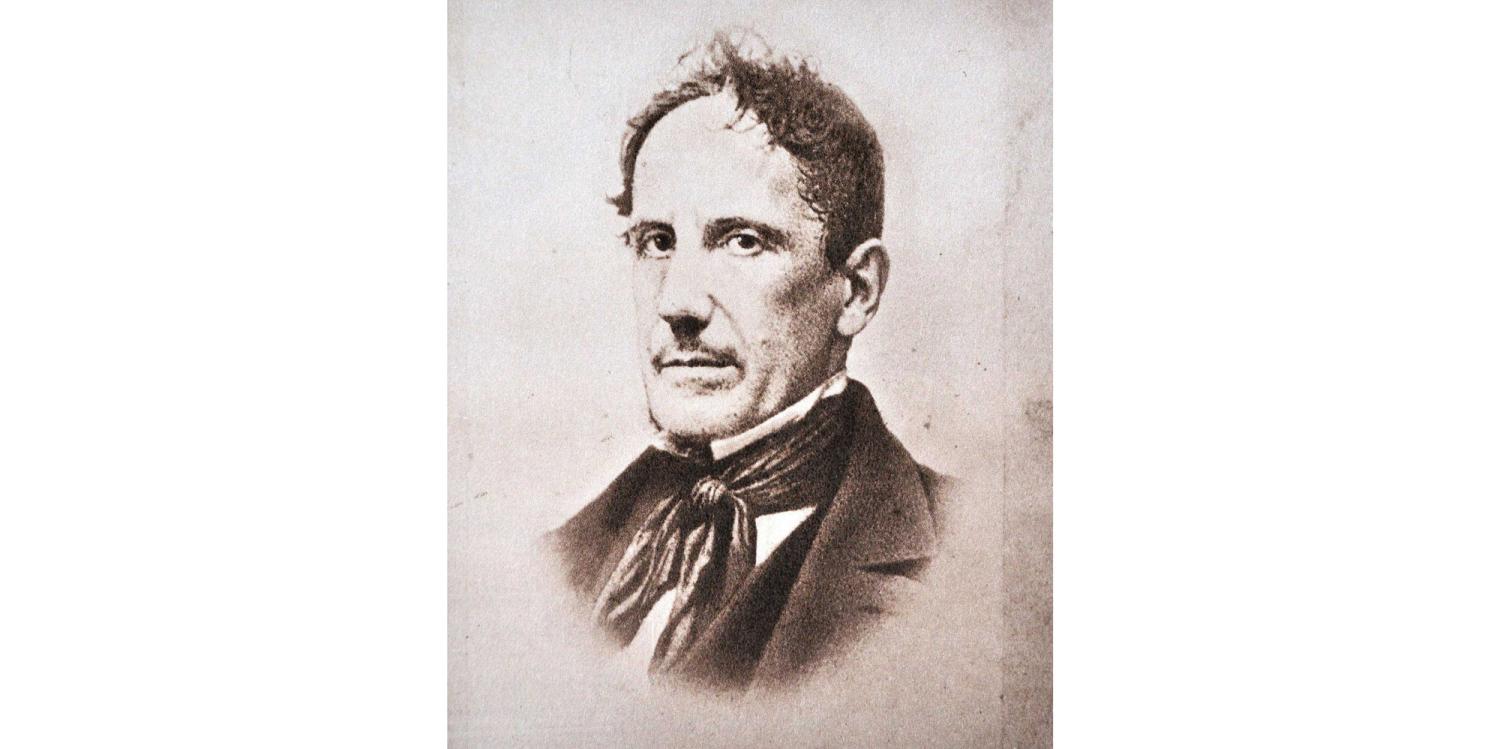Sul testo
La vita di Giuseppe Gioachino Belli
La poesia dialettale: Sonetti (1819-1847)
La produzione poetica di Giuseppe Gioachino Belli c’è una scelta simile a quella di Carlo Porta: l’uso del dialetto, il tono realistico e popolare e l’attenzione alle classi più povere. Tuttavia, mentre il milanese è parlato (e scritto) dall’intera società lombarda, nel contesto romano il dialetto è usato solo dai ceti popolari e le opere di Belli, anche per la loro componente di critica sociale, vengono accolte con diffidenza. I suoi Sonetti in romanesco (ben 2279) furono composti lungo un arco di tempo che va dal 1819 al 1847, ma rimasero clandestini durante la vita dell’autore e furono pubblicati solo in parte con i tagli operati dalla censura nel 1865. Nell’Introduzione alla sua opera, scritta nel 1831, il poeta sottolinea la scelta dell’attualità storica e l’attenzione per le condizioni di vita dei ceti più poveri rappresentate con accurato realismo. Per questi, l’esistenza è precarietà e la sola certezza è la morte; mentre le persone di potere si contraddistinguono per l’ingozzarsi e il rimpinzarsi, il «maggnà»: il mondo si divide tra quelli che magneno» e quelli che «nun magneno». Bersaglio polemico della poesia di Belli sono coloro che esercitano il potere, soprattutto il papa e il clero.