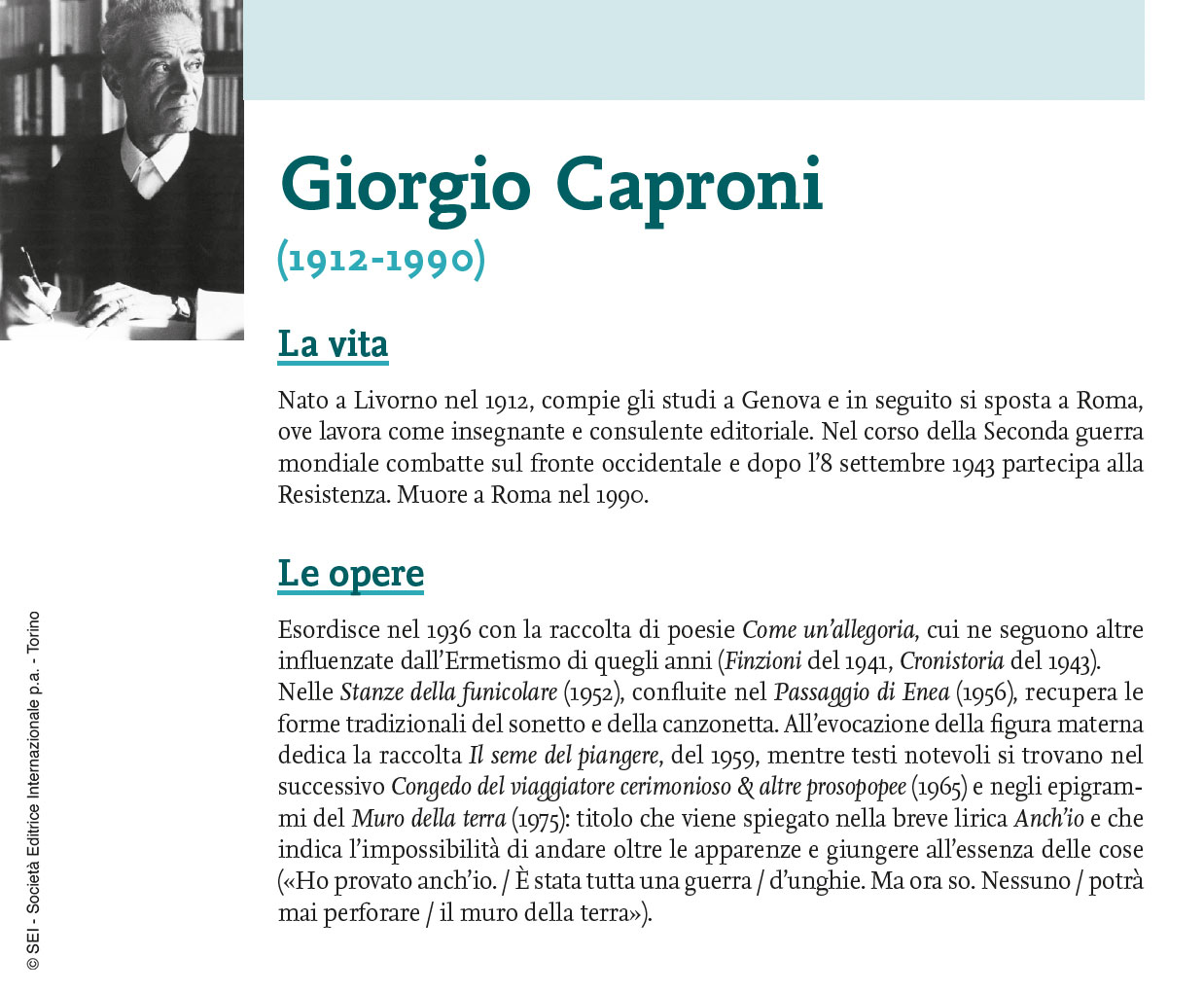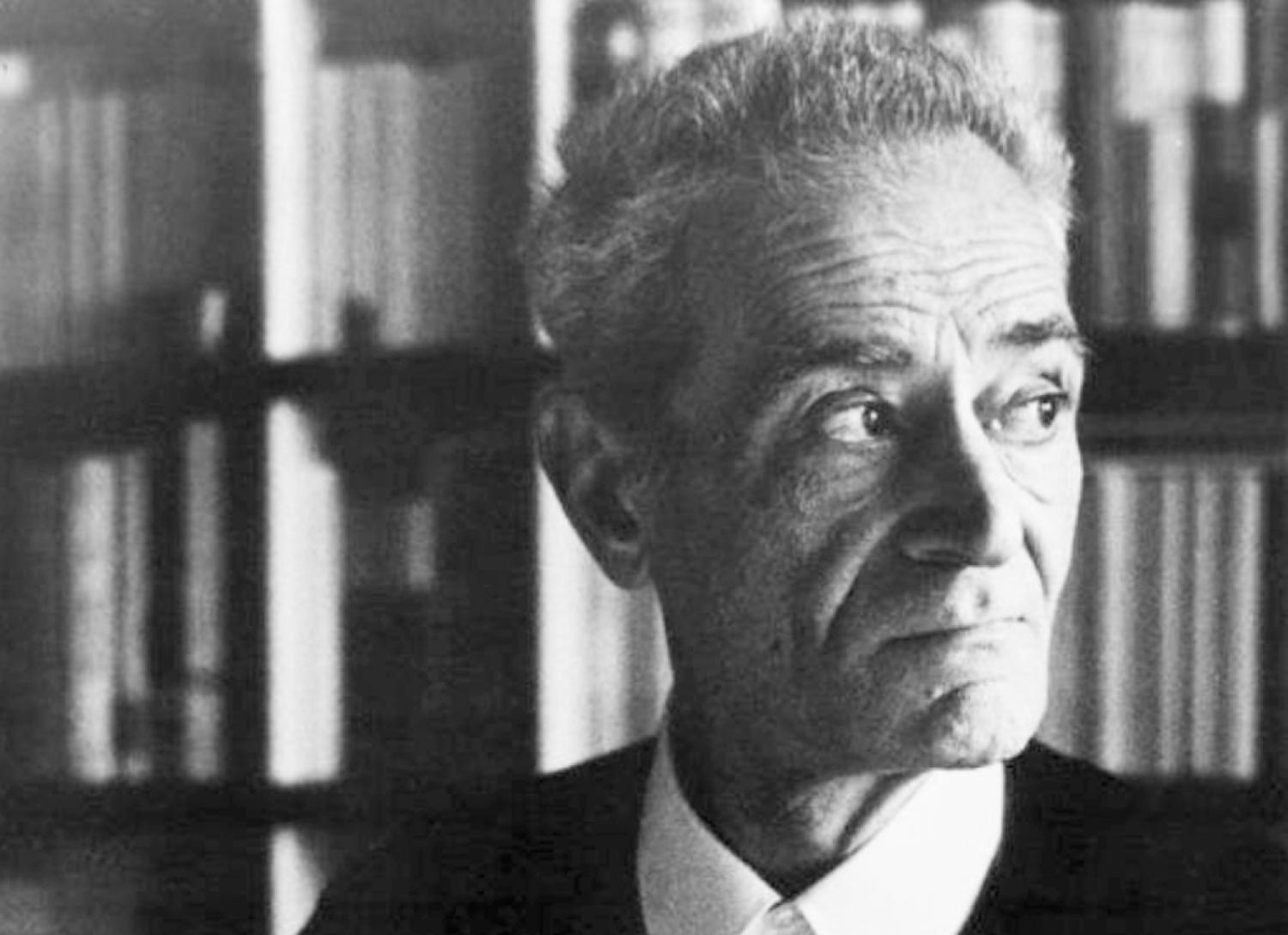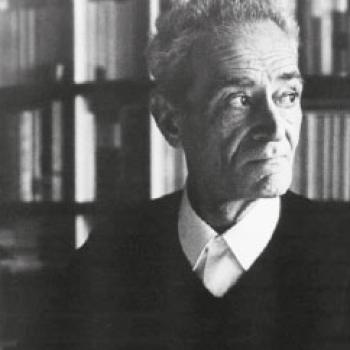
Sul testo
La vita e le opere di Giorgio Caproni
Il seme del piangere (1959) e le altre opere
Nato a Livorno, ma vissuto a Genova e nel dopoguerra a Roma, Giorgio Caproni tende a mediare tra le forme chiuse della tradizione italiana e tonalità più prosaiche, anche di derivazione popolare: si assiste a una restaurazione dei versi classici (endecasillabi, settenari, ottonari), con cadenze musicali e un uso libero della rima.
I temi di fondo si legano alla transizione dalla civiltà contadina alla nascente società industriale, a oggetti umili e quotidiani (La bicicletta) o alle memorie affettive e autobiografiche (le frequenti evocazioni della madre, specie in Cronistoria del 1943 e nei Versi livornesi che aprono la raccolta Il seme del piangere del 1959). Si fanno gradualmente strada anche una tensione metafisica – nelle domande senza risposta su Dio e sulla morte – e il richiamo alle metafore mitiche del “passaggio”, del viaggio esistenziale e del muro invalicabile (rispettivamente nelle raccolte Il passaggio di Enea del 1956, Congedo del viaggiatore cerimonioso del 1965 e Il muro della terra del 1975). L’esito della lunga ricerca di Caproni è la percezione vertiginosa del mistero e del silenzio abissale in cui l’uomo è avvolto, a cui possono sottrarlo soltanto gli esili segni della breve esperienza terrestre: le cose amate e consuete, i luoghi, i ricordi.
Nuove esperienze poetiche: i post-ermetici
Nel secondo dopoguerra l’Ermetismo continua a costituire un punto di riferimento fondamentale, che tuttavia viene gradualmente superato da nuove esperienze poetiche. Prende forma quella che è stata definita la “linea antinovecentesca”, una tendenza orientata verso la prosaicità e riscontrabile, peraltro, anche nell’evoluzione dell’opera di autori legati all’Ermetismo, quali Montale, Quasimodo e Luzi.
Secondo alcuni critici, prevale in definitiva l’eredità di Saba, con la sua propensione a un lessico e a una struttura apparentemente facili, capaci di realizzare una comunicazione più immediata e diretta. Dalla centralità dell’analogia e del simbolismo, e dal linguaggio oscuro e allusivo, si passa a forme epigrammatiche (in Penna, ma anche nell’ultimo Montale), oppure dialogiche (in Caproni) o apertamente narrative, come in Attilio Bertolucci, mentre in altri casi – in Fortini, specialmente, o in Sereni – si sviluppa nei versi un’argomentazione e un ragionamento, in cui il lettore è coinvolto e persuaso con toni più o meno polemici o dubitativi. A livello tematico è ricorrente il motivo dell’alienazione dell’individuo alle prese con la moderna società dei consumi e con la rivoluzione tecnologica in corso.