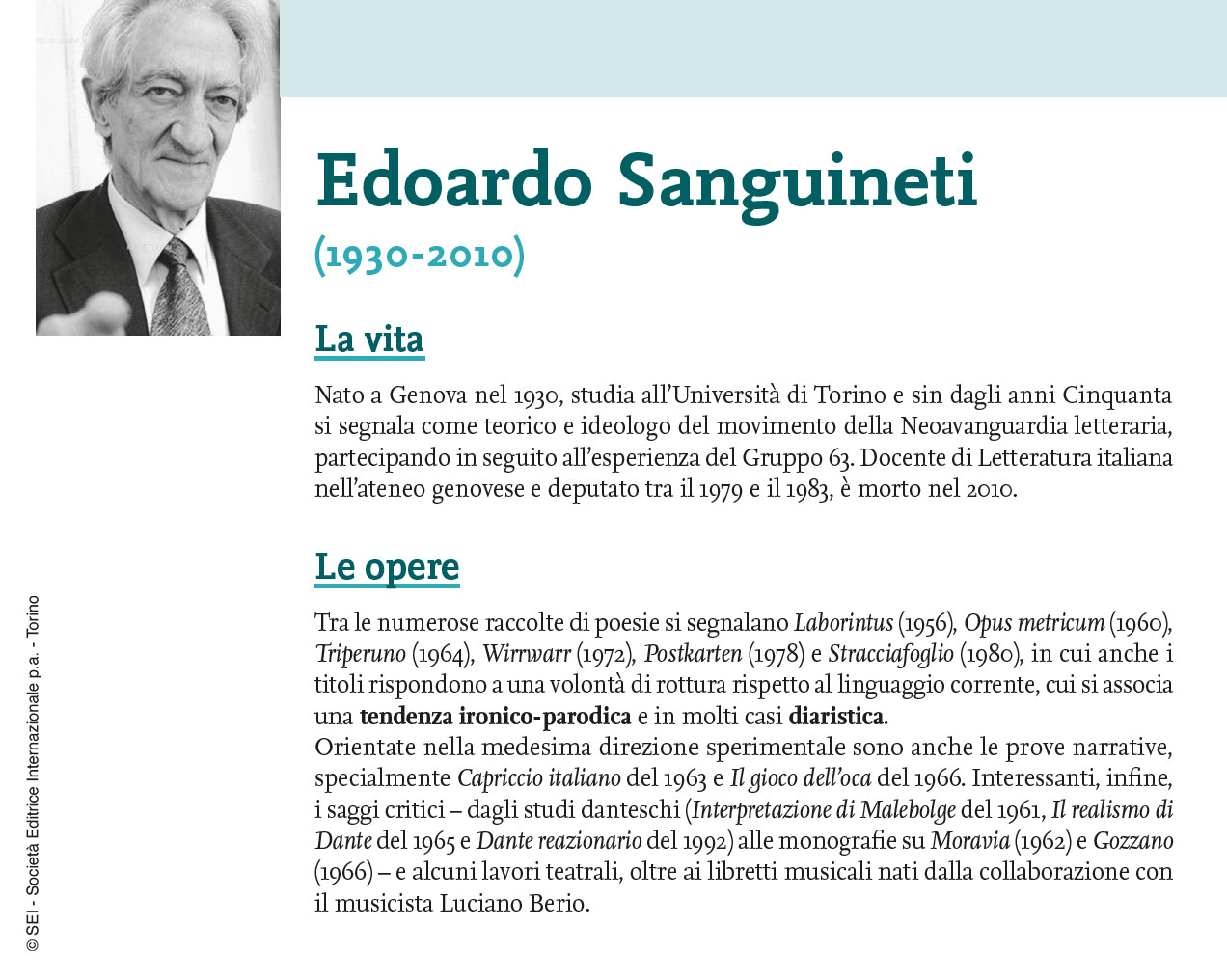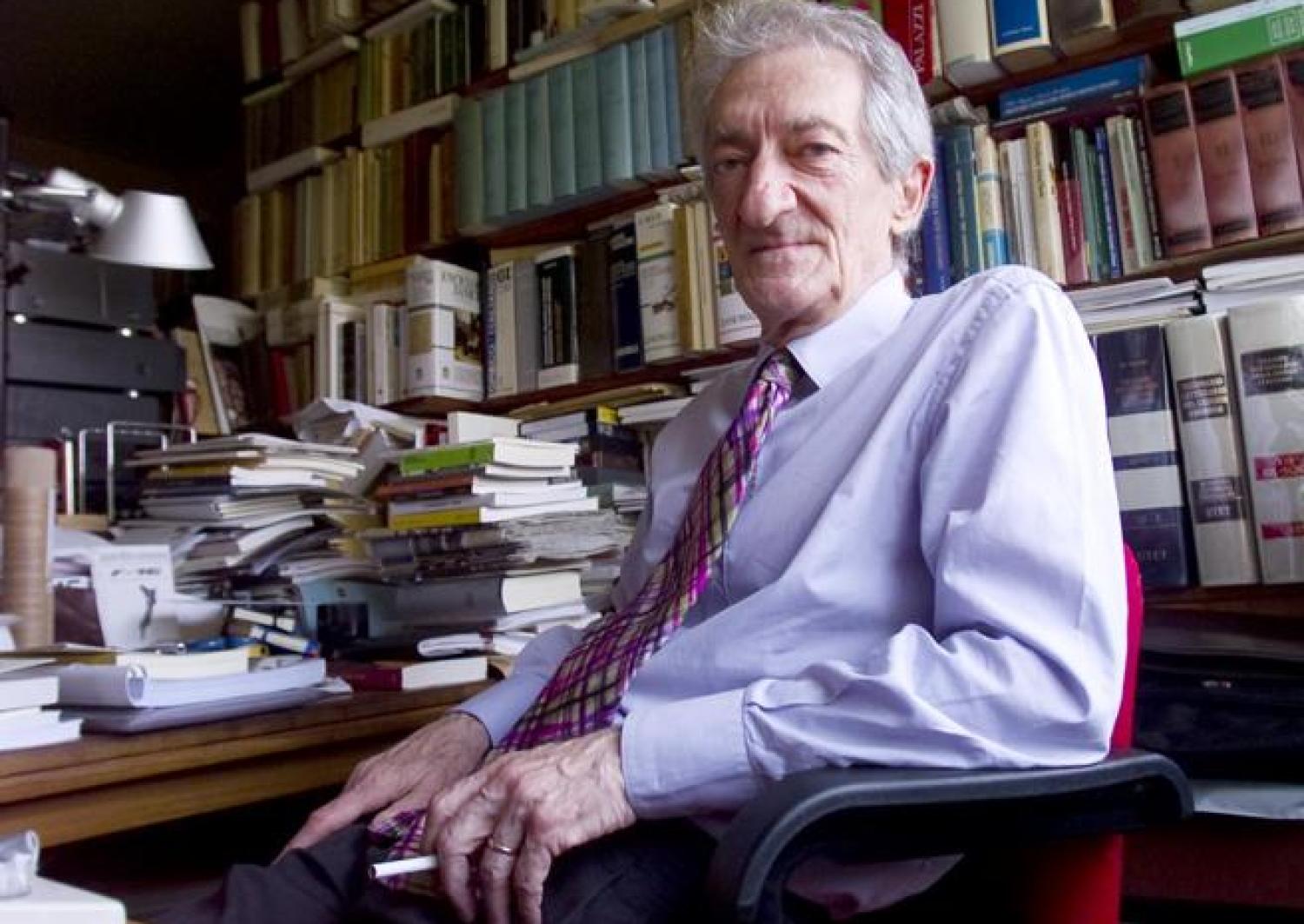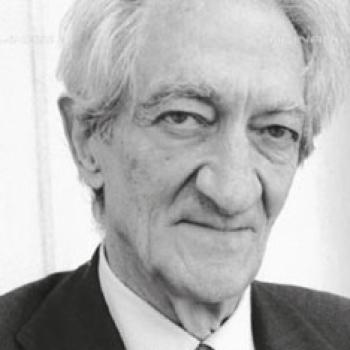
Sul testo
La vita e le opere di Edoardo Sanguineti
Laborintus (1956)
La punta avanzata del Gruppo 63, e punta di diamante dell’antologia de I Novissimi (dove il titolo, derivato dal libro biblico dell’Apocalisse, significava le cose ultime, o estreme), è senz’altro Edoardo Sanguineti, che già nel 1956 aveva dato alle stampe un libro straordinariamente anticipatore e innovativo.
La sua prima opera, Laborintus, è una faustiana discesa all’inferno che ha tutto l’aspetto di un supremo divertimento: la tecnica della confessione psicanalitica mima in verità una ricognizione nella mitologia collettiva, dove l’alchimia e le larve dei sogni, le scoperte erotiche e filologiche, il decadimento sociale, la suggestione dottrinale di una cultura tra medievale e barocca, le figure dell’esperienza quotidiana, s’inseguono per giustapposizioni.
(Giuliani, in I Novissimi)
È costante, in Sanguineti, il riferimento non soltanto alle avanguardie europee, ma anche alla tradizione anticlassicista e plurilinguista (dai maccheronici del Cinquecento al barocco), oltre che al Faust di Goethe e al poema di Dante: la sua «Palus Putredinis» – palude della putredine, da attraversare per discendere agli Inferi – diventa, per esempio, allegoria della società industriale e capitalistica, più ancora di quanto lo sia la «terra desolata» evocata dal poeta inglese Thomas Eliot nell’omonimo componimento.
Anche i riferimenti al linguaggio della psicanalisi di Jung e al simbolismo degli archetipi confermano il legame con il Surrealismo e il tentativo di un’immersione nelle profondità infernali dell’inconscio individuale, da cui si può risalire a quello collettivo, per coglierne i meccanismi nascosti che generano miti e paure. Altrettanto interessanti sono le soluzioni formali, basate su un ritmo dei versi non più determinato dagli accenti ma “atonale”. Anche il rifiuto della metrica tradizionale è teso a provocare nel lettore un effetto di choc e straniamento.
La Neoavanguardia e il Gruppo 63
Un evento clamoroso nel panorama letterario italiano del secondo dopoguerra è rappresentato dall’uscita nel 1961 dell’antologia I Novissimi – Poesie per gli anni ’60 – curata da Alfredo Giuliani – che raccoglieva testi del curatore e di Elio Pagliarani, Edoardo Sanguineti, Nanni Balestrini e Antonio Porta.
I cinque poeti erano reduci dalla collaborazione alla rivista «Il Verri» di Luciano Anceschi, indirizzata verso lo sperimentalismo e attenta ai teorici dello Strutturalismo. Li accomunava la tendenza a lasciarsi alle spalle non solo l’insistenza dei neorealisti sui “contenuti”, ma anche il Neocrepuscolarismo che intravedevano in Pasolini, ovvero il richiamo a una materia autobiografica riproposta in toni elegiaci.
Per essere contemporanei di se stessi – aggiornati, diremmo oggi – occorreva a loro avviso accogliere la rivoluzione introdotta dalla tecnologia, dalla cultura di massa e dai mass media, e procedere con violenza e coraggio verso la disgregazione della sintassi (asintattismo), l’abbandono delle attese imposte dalla consuetudine (straniamento), l’allontanamento di ogni tentazione individualistica e autobiografica (riduzione dell’io) e il rifiuto di ogni compiacimento edonistico, sia sul piano lessicale sia su quello metrico-musicale (verso atonale).
In un successivo convegno del 1963 a Palermo, i cinque – cui altri si aggiunsero, tra cui Umberto Eco – diedero vita al “Gruppo 63”, espressione collettiva e organizzata della cosiddetta “neoavanguardia”, che poneva alla base del proprio programma l’insurrezione contro il “mercato” e contro la mercificazione del mondo, da attuarsi attraverso lo smantellamento di un linguaggio “alienato” e ridotto a strumento del potere costituito. Si trattò di un’esperienza molto significativa, resa tuttavia breve dalle divergenze che presto separarono i suoi promotori.